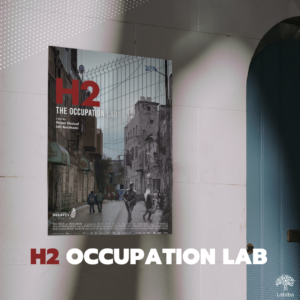Barriere materiali e psicologiche sono quelle che dividono Yacine Al Bazaaz e Joseph Silberg, e le rispettive famiglie, una palestinese e una israeliana. Muri difficili da abbattere a causa del costrutto storico che entrambe le famiglie si portano dietro. Due mondi che sembrano non doversi incontrare mai, ma che, per puro caso, finiscono faccia a faccia. Il film Il figlio dell’altra parla proprio di questo. Due situazioni così culturalmente diverse che sono destinate a scontrarsi, ad accantonare le differenze in nome di qualcosa più grande dell’odio: l’amore per i figli.
Ricerca dell’identità
Fino al loro diciottesimo anno d’età, i due giovani vivono indisturbati. Joseph punta a diventare un musicista, Yacine ha in programma di frequentare la facoltà di medicina. La loro vita cambia radicalmente quando scoprono di essere stati scambiati alla nascita, nel 1991, durante un’evacuazione improvvisa dall’ospedale di Haifa per via dei bombardamenti durante la guerra del Golfo. I due ragazzi si devono ora interfacciare con la ricerca della propria identità. Insieme alla perdita del proprio io perdono anche la propria religione: il rabbino riconosce più ebreo Yacine rispetto a Joseph perché di sangue ebreo.
L’amore materno
Sebbene a pochi chilometri di distanza, le loro esperienze non potrebbero essere più diverse. La famiglia di Joseph vive a Tel Aviv, città ricca e piena di prospettive; gli Al Bazaaz risiedono nei territori occupati della Cisgiordania, posto precario e povero, con poco margine di crescita professionale. Le sostanziali differenze, politiche ed economiche, si risentono negli incontri impacciati fra le famiglie, con i padri che si rinfacciano le dissonanze politiche con astio e pregiudizi. Le madri, invece, si fanno guidare dal proprio cuore. Preferiscono appianare le divergenze per poter dare adito all’amore viscerale che le unisce non solo al figlio che hanno cresciuto per diciotto anni, ma anche a quello che hanno custodito in grembo per nove mesi. Con il passare del tempo, Alone e Saïd riescono ad accantonare le discussioni per unirsi nella drammaticità della stessa situazione.
“Il mio peggior nemico”
Situazione che il fratello palestinese di Yacine, Bilal, non è in grado di affrontare perché troppo diffidente verso gli ebrei, che vede come capro espiatorio per la decadenza della propria civiltà. Andando avanti, anche lui riuscirà ad abbattere le barriere mentali e i pregiudizi che tanto ha sostenuto per tutta la vita. I due figli ebreo-palestinesi si ritrovano a sostenersi nel loro nuovo, inaspettato mondo, fatto di un dualismo identitario. Questa scoperta del vero sé li porterà a frequentarsi sempre di più, sostenuti dall’amore e dal supporto delle madri. Emblematica è la frase di Yacine: “Sono il mio peggior nemico e devo volermi bene lo stesso”. Perché, per quanto la sua essenza ebreo-palestinese possa essere conflittuale, l’affermazione della propria identità non può prescindere dall’accettazione e comprensione dell’altro.
La regista francese Lorraine Levy vuole trasmettere tradizione, storia, intimità e speranza. Allo stesso tempo ci invita a guardare “l’altro” con occhi diversi, senza pregiudizi che sovrastino l’identità delle singole persone. Levy ha scelto di non rappresentare la questione israelo-palestinese attraverso la guerra. Piuttosto, ha incentivato una chiave di lettura basata sulla sensibilità, la sofferenza, l’umanità di due famiglie costrette a fronteggiare il loro peggior nemico, per arrivare a capire che, in realtà, sono molto più vicine di quanto potessero mai immaginare.
di Annachiara Magenta